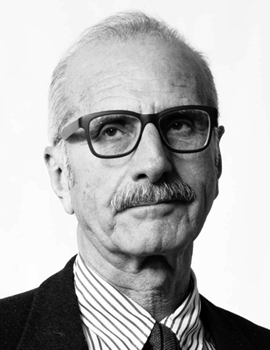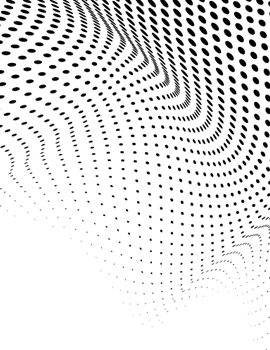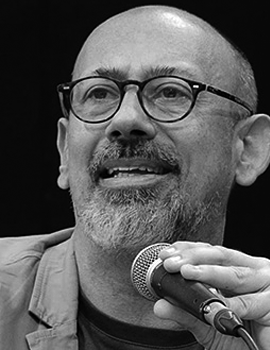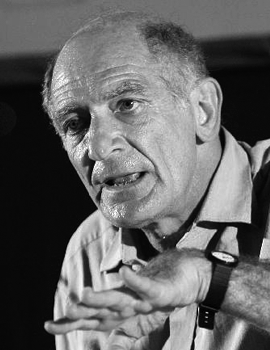Dalla pseudospeciazione
al capro espiatorio
Pseudospeciazione è un termine poco usato nelle scienze umane e sembra quasi sconosciuto a chi si interessa di neuroscienze e della loro applicazione ai temi antropologici. Credo invece che si sia toccata, con l’introduzione di questo termine in psicologia sociale e poi in etologia umana, una questione fondamentale, cioè un fenomeno che riguarda i fondamenti stessi della cultura umana, perché cerca di spiegare le modalità della differenziazione culturale, differenziazione che si spinge fino a creare comportamenti che superano le inibizioni legate all’appartenenza alla stessa specie. In questo senso gli umani non riconoscono come umani altri umani, possono comportarsi nei loro confronti come nei confronti di altre specie, creano dunque di fatto una “pseudospecie” che, come tale, può essere aggredita fino alla uccisione – un evento che, tra primati e mammiferi, accade solo in situazioni molto particolari o per eccezione – mentre in nessun modo possiamo rubricare la guerra tra diversi gruppi umani come eccezione. La storia ne da prove schiaccianti.
La pseudospeciazione, teorizzata dall’etologia umana, può costituire una base per affrontare l’uso culturale delle costruzioni del “capro espiatorio” come condizionamento dei comportamenti collettivi alla base del superamento metodico delle inibizioni che limitano a certe situazioni o proibiscono del tutto di distruggere membri della stessa specie tra mammiferi. Le tecniche di mostrificazione tendono a trasformare la percezione dell’altro in qualcosa di estraneo così minaccioso e svalutato da poterlo sopprimere. Ma con ciò si produce una sorta di moral injury che riguarda tanto le vittime che i carnefici. Questo nesso sembra essere decisivo per costituire un campo transdiciplinare che colleghi gli apporti delle scienze biologiche, dell’etologia e delle neuroscienze alle scienze sociali e umane, alla psicologia e alla dimensione etica e politica.
Tra i mammiferi l’uccisione di un altro conspecifico avviene solo in circostanze molto particolari, oppure come conseguenza accidentale di uno scontro, perché il comportamento violento è ritualizzato in movimenti tipici e l’azione istintuale della lotta viene neutralizzata non appena il rivale accetta la sconfitta, si sottomette o abbandona il campo. Proprio l’opposto di quanto accade nelle più diverse, nel tempo e nello spazio, culture umane: i rituali che preparano alla sfida violenta sono tesi alla modificazione della percezione per riuscire a superare l’inibizione naturale. Proprio seguendo questa linea di ragionamento Konrad Lorenz attribuì all’invenzione delle armi da fuoco un ruolo chiave nella estensione e nell’intensificazione delle guerre: i proiettili colpiscono a distanze molto più grandi che non nello scontro diretto, la distanza attutisce la percezione dell’altro e quindi aiuta a superare l’inibizione a uccidere. I rituali per cambiare la percezione non includono soltanto la preparazione dei sensi attraverso stati alterati di coscienza prodotti da movimenti, suoni, costumi o divise speciali, ma vengono spesso intensificati, fino al parossismo, attraverso l’ingestione di sostanze. Ieri come oggi. Ancora nelle guerre inter-jugoslave della fine del secolo scorso chi aveva pochi soldi usava la grappa, come nella prima o nella seconda guerra mondiale, oppure ci si drogava con stupefacenti più efficaci e più pesanti. Diverse testimonianze portano a ritenere che anche tra i top-gun dell’aviazione statunitense durante le ultime guerre mediorientali, in Iraq e in Afghanistan, le sostanze dopanti abbiano avuto larga circolazione. Eppure sappiamo che l’obbiettivo, visto da un aereo da combattimento, compare come una crocetta su uno schermo: gli umani sono invisibili, la distruzione un suono lontano e un’immagine astratta. Potremmo concludere che bisogna neutralizzare il circuito della risonanza empatica: “benché noi si sia soltanto all’inizio della esplorazione della neurobiologia dell’empatia, qualche indicazione comincia ad emergere. Dato che la corteccia si è evoluta all’inizio per guidare il comportamento motorio, allora ha senso affermare che l’attivazione somatica e motoria che ha ancora un carattere primitivo possa servire come infrastruttura delle emozioni, dei processi cognitivi e del pensiero astratto. Se prendiamo il circuito dei neuroni specchio come centro di un sistema più ampio che includa altri aspetti addizionali del cervello sociale, possiamo cominciare a cercare come si possa costituire un network dei fenomeni della risonanza e dell’empatia”1.
Queste ricerche e queste scoperte mi pare confermino le teorie sulla pseudo speciazione, formulate all’inizio negli anni sessanta del Novecento e riprese poi negli anni Novanta da Eibl Eibesfeldt.2 Ci vuole cioè una profonda trasformazione culturale della percezione per neutralizzare il circuito empatico e condurre la reazione ben al di là dell’esperire quel che l’altro prova in modo pre-cognitivo, bisogna che intervenga una ristrutturazione valutativa che decida che l’attacco al “nemico” possa superare le barriere di specie e lo possa quindi trattare come altro dall’umano.
È caratteristico di molte culture e di molti popoli chiamare se stessi “popolo degli uomini”, possiamo ritrovare il senso di questo appellativo tra i Rom come tra i Cheyenne, per non fare che due esempi tra le decine possibili. D’altra parte, se si volesse sottilizzare, persino l’espressione, di per sé universalmente umana, che ci presenta il pensiero aristotelico quando dice l’umano come “animale politico” o come coloro che “hanno il logos” – con tutta la polivalenza del termine logos, è fuori discussione che contenga il linguaggio – ha un suo complemento svalutativo nell’ uso del termine “barbari”, perché guarda ai non-greci come a coloro che “balbettano”: dunque i non-greci sono umani deficitari perché non possiedono appieno il logos che fa umani gli umani. In Grecia e a Roma bisogna aspettare gli epicurei, gli stoici e, soprattutto, i cristiani e Paolo di Tarso per arrivare a un universalismo pieno. Salvo poi, diventato il cristianesimo religione di stato, trovare infiniti modi per ricominciare le manovre di esclusione di questi e di quelli, degli eretici e degli apostati, dei “perfidi giudei” e dei musulmani, delle streghe e dei “selvaggi” del nuovo mondo, ai quali alcuni volevano negare una vera anima umana, come a volte accadeva anche per le donne. Questo stesso processo, nonostante le leggende esotiche sull’Oriente pacifico, in modi e tempi diversi e sempre senza coinvolgere l’intero spettro della storia religiosa, è accaduto, e accade, tra popolazioni di ogni religione ( vedi la tragedia dei Rohingya musulmani vittima di pulizia etnica da parte della maggioranza buddhista del Myanmar) e di ogni ordinamento politico-sociale ( il genocidio contro i nativi americani e quello contro gli aborigeni sono stati perpetrati in due paesi modello dal punto di vista della storia delle istituzioni democratiche ).
Dunque umani in senso pieno siamo sempre “noi”, e sottoumani o non umani sono sempre “gli altri”. Questo processo sembra caratterizzare, appunto da “sempre” (cioè da quando abbiamo sufficienti reperti per parlare di popolazioni con una cultura loro propria), la formazione di una certa “identità” di gruppo, con caratteri relativamente stabili, o meglio, con caratteri che possono mutare con una certa lentezza. Norme comuni, nome della popolazione, reti di conoscenza reciproca, politiche della parentela, creazione di alleanze con altri gruppi, scambi e commerci, rimandano a una appartenenza collettiva, tanto quanto, all’opposto, richiedono un atteggiamento comune ostile nei confronti dei “nemici”. Gli estranei sono pregiudizialmente visti con diffidenza: se questa barriera per qualche ragione viene superata, allora devono entrare a far parte a pieno titolo della comunità. Per fare un solo esempio, tra gli Apache Bedonkohe, la tribù di Geronimo, era giusto derubare o uccidere un membro di una tribù nemica, o un bianco, ma se l’estraneo veniva accolto, allora entrava nella rete di parentela esattamente come un membro del gruppo, diventava cioè fratello, zio, cugino di questo e di quello. Chi devia peraltro dalle regole collettive viene in qualche modo punito, in modo formale o informale. Penso che questo meccanismo sia stato funzionale per decine di migliaia di anni: l’unità del gruppo è la prima e la più importante risorsa in epoche nelle quali le tecniche a disposizione per poter usare le risorse di un certo territorio sono tecniche fondamentalmente legate alle persone stesse che devono apprenderle in un lungo apprendistato esperienziale e che, quindi, si identificano con le loro abilità fisiche e psichiche. Le tecniche sono cioè scarsamente utilizzabili indipendentemente dalle abilità specifiche incorporate nei singoli appartenenti al gruppo. Tecniche e livello demografico – bilancio delle nascite e delle morti, uscite e entrate nel gruppo – sono correlati dell’estensione territoriale e delle risorse naturali disponibili : questo fa sì che la variazione quantitativa e qualitativa nella composizione del gruppo sia importante da controllare. Le tradizioni sono meccanismi provati dall’esperienza che dirigono le modalità di sopravvivenza, e la loro relativa fissità e “sacralità” contribuisce a fornire una guida non soggetta ai conflitti di potere interni. Per questo insieme di motivi credo che l’unità di gruppo sia il bene fondamentale che deve essere tutelato in queste condizioni per assicurare la sopravvivenza dei singoli. Le pene per chi la mette in pericolo sono severe. L’esclusione può portare a una condanna a morte di fatto, o, in ogni caso, a una vita difficilissima da “bandito” o da esule. Ma l’unità del gruppo e i suoi confini possono essere difesi solo elevandoli a una dimensione inarrivabile da altri, deve essere sancita una qualche “superiorità culturale”. Penso che queste siano buone ragioni per spiegare il fenomeno di quello che Ei- bl-Eibesfeldt, richiamandosi a ricerche di E. H. Erikson e M. e C. W. Sherif, già pubblicate nel 1966, chiama “pseudospeciazione culturale”3. Interessante è la sua ricostruzione e il suo commento dell’esperimento degli Sherif: un gruppo di ragazzini di undici/dodici anni viene portato in campeggio, poi le amicizie spontanee vengono artificialmente separate con una divisione in due gruppi. La cooperazione che ne seguì portò alla dissoluzione delle vecchie amicizie e alla creazione di uno stile di gruppo e di modi diversi di affrontare i problemi, di gerarchie interne, ma anche di un gergo comune, di segreti e di giochi diversi dagli altri. Nella fase successiva si passò alla competizione sportiva con premi per i vincitori. L’ostilità tra i due gruppi crebbe fino a forme di confronto fisico. Ma, una volta riunificati i gruppi dando a tutti compiti comuni, la polarizzazione venne meno, soprattutto poi quando ai due gruppi venne indicato un “nemico comune”. Mi sembra che proprio questo esperimento renda ragione della plasticità dell’identità di gruppo a partire dalla cooperazione di fatto (si direbbe l’organizzazione della divisione tecnica del lavoro) e dalla facilità di cementarne l’unità costruendo un “nemico comune”. Il nemico è stato efficacemente costruito, nella nostra storia plurimillenaria, come “inumano”, come una sorta di “mostro”. E lo si comprende bene: appunto in quanto altro e mostruoso la sua percezione può essere alterata al punto da farlo sembrare così estraneo a noi da poterlo opprimere o uccidere come se fosse di un’altra specie. Si può ingenerare un disgusto tale da sovrascrivere i meccanismi naturali del mutuo riconosci- mento di specie. La storia delle culture e delle società, antiche e moderne, ne è troppo ricca per stare a esemplificare questi comportamenti distruttivi.
Si tratta del rovesciamento del riconoscimento specie-specifico in misconoscimento, secondo gradazioni diverse: dal misconoscimento assoluto, che comporta la distruzione del nemico come indegno persino di essere riconosciuto come degno avversario, al misconoscimento che arriva fino alla uccisione ma che tributa onore alle virtù dell’altro. Il misconoscimento è comunque un fenomeno endemico e riguarda tutte le forme sociali storiche delle quali abbiamo testimonianza: l’umiliazione che comporta la perdita della autonomia del corpo proprio e quindi attacca la fiducia di base negli altri e in se stessi; l’esclusione che nega i diritti in quanto membro di una data comunità; il disprezzo di modi di vivere, credere e pensare che intacca la stima di sé e del proprio gruppo, ogni forma di moral injury.4
Qui si toccano le radici dell’umano perché nel riconoscimento originario – come per tutti i mammiferi, ma in tempi e modi relativamente alle altre specie assai più lunghi e intensi – si crea, attraverso lo iato generato dal processo neotenico e nella esposizione a pulsioni e stimoli che vengono mano a mano padroneggiate nel procedere del processo educativo, il rimodellamento culturale. Proprio perché, dunque, il misconoscimento mina le basi del riconoscimento originario esso è così potente sia per i perpetratori che per le vittime. E diventa uno dei meccanismi fondanti delle identità collettive, delle maschere sociali. Possiamo supporre che tutto ciò che la maschera sociale della identità di gruppo cerca di nascondere, di reprimere o di rimuovere, venga a creare ciò che possiamo chiamare, a secondo dei lessici, parti dell’inconscio, oppure, più specificatamente, aspetti d’ombra, o ancora, come preferisco chiamare io questi composti psichici, “doppi impresentabili”. Sono proprio questi tratti nascosti e disprezzati che vengono proiettati sugli altri, fornendo il materiale fantasmatico per la creazione del nemico come mostro, e, all’interno del gruppo come all’esterno, per individuare i “capri espiatori”. Il capro espiatorio è una ottima esemplificazione del processo di pseudospeciazione e ha storicamente funzionato nel giustificare l’annientamento del nemico esterno e di quello interno, garantendo, nei momenti di crisi, l’omogeneità dei gruppi e delle organizzazioni politiche, fino alla creazione degli stati.
Jung, nel Libro Rosso e Neumann in Psicologia del profondo e nuova etica5 leggono rispettivamente la prima guerra mondiale e la forma generale della proiezione dell’ombra collettiva, utilizzando la figura-concetto del capro espiatorio, volta a volta scelto negli strati alti, socialmente o intellettualmente, del gruppo di appartenenza, oppure e più frequentemente tra gli esclusi, gli svantaggiati e, soprattutto, gli stranieri. In Neumann poi la dinamica è costruita differenziando il funzionamento psicologico della repressione e della rimozione, correlate a strati sociali e fasi storiche, ed espresse esteriormente, in modi più o meno inconsci, nelle persecuzioni delle “vittime sacrificali”, designate secondo le occasioni che si presentano. Così la figura dell’altro viene demonizzata, mostrificata, resa quindi disponibile a ogni sorta di angheria e di tortura, fino all’eliminazione.
Il nesso quindi tra le dinamiche di riconoscimento e misconoscimento, la divergenza culturale fino alla pseudospeciazione e la funzione di concentrazione e deviazione della violenza distruttiva sui capri espiatori scelti, è stabilito.
Se si sospende il giudizio morale – una sospensione necessaria se, prima di giudicare, spesso in modo anacronistico e decontestualizzato, si vuole cercare di spiegare e di comprendere – si può capire la funzione necessaria della pseudospeciazione in condizioni di forti differenze geografiche, sociali e culturali, in competizione per l’utilizzo di risorse spesso scarse, date le tecniche disponibili e il loro incremento lento, dovuto anche alla subordinazione delle innovazioni alla tradizione come deposito di saperi, verificato da esperienze immemoriali del gruppo che in essa si riconosce.
Fino alla rivoluzione del capitalismo industriale, nel complesso, l’innovazione è stata subordinata alla tradizione6, corrispondentemente le tecniche, e quindi la divisione del lavoro sociale, non hanno oltrepassato un livello che possiamo chiamare “interdipendenza locale”. Con l’avvento del capitalismo globale7 l’interdipendenza di tutti da tutti e da tutto è diventata di fatto – anche se ben lontana dall’essere penetrata nella coscienza collettiva – la condizione base di ogni branca delle tecniche e del lavoro sociale universale, così come, ovviamente, dei mercati delle merci e dei servizi. La politica stessa, che lo riconosca o meno, dipende dall’andamento globale di queste variabili tecnico-economiche e dai loro risvolti sociali. Che questo immane rivolgimento storico, che ha fatto per la prima volta il suo ingresso nella storia degli umani, produca continui salti in avanti e capriole all’indietro, è solo l’ovvia conseguenza del movimento di fondo. Dai fondamentalismi ai sovranismi il movimento regressivo è in pieno sviluppo, ma ogni sua vittoria sarà parziale, locale, effimera, evemenenziale. Sulla lunga durata, diceva Keynes, saremo tutti morti, è vero, ma questo non ci esime da guardare i corsi e i ricorsi della storia cercando di saggiarne la consistenza e la dimensione temporale, distinguendo le tendenze principali dagli aspetti secondari, di breve o, al massimo, medio periodo. La rotta non è reversibile: il capitalismo globale è l’inevitabile sbocco della storia del capitalismo e della sua vittoria.
Chi vuole cercare di comprendere il suo tempo nella sua traiettoria può scorgere – pur senza poterne determinare con precisione i tempi di realizzazione – la fine della funzionalità della pseudospeciazione. L’umanità è diventata realmente universale, anche se il soggetto non sono state religioni e concezioni del mondo che pure ne hanno accompagnato e precorso la destinazione. La pseudospeciazione e il suo corteo di guerre civili intra-specifiche, di violazioni, di esclusioni, di umiliazioni e di disprezzo per l’alterità umana, diventerà sempre più controproducente, inefficace e autodistruttiva per tutti i competitori. Quante catastrofi saranno necessarie perché l’umanità arrivi a capire cosa è diventata – cioè appunto umanità come universale concreto – certo non è dato saperlo: ogni sforzo tuttavia che si ponga nella direzione di senso della costruzione, spirituale e materiale, della cooperazione globale, non è solo giusto eticamente, ma è giusto eticamente perché adeguato alla realtà dei processi, e dunque vero. Oggi questo orientamento appare come utopia e, al momento, lo è. Ma l’utopia indica una direzione e questa direzione è tanto eutopica quanto “scientifica”, almeno per quel tanto di sapere serio che è possibile nelle scienze umane.
Note:
- L. Cozolino, The Neuroscience of Human Relationships, New York-London: W. W. Norton&Company, 2006, p. 204. (traduzione mia). Ma cfr. Come sintesi di un lungo percorso di ricerca sui neuroni specchio G. Rizzolatti, C. Senigaglia, Specchi nel cer- vello. Come comprendiamo gli altri dall’interno, Raffaello Cortina, Milano, 2019.
- I.Eibl-Eibesfeldt, Etologia umana. Le basi biologiche e culturali del comportamento (1984-89), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino, 1993.
- Ivi, pp. 192-195 e 210-215. Eibl-Eibesfeldt tuttavia ritiene che esistano “adatta- menti filogenetici per il mantenimento della norma di gruppo” e porta come una delle prove il fatto che sia “necessario educare le persone alla tolleranza”. Ma tra il tempo lungo di una costante culturale e un adattamento filogenetico corre una netta differenza, e la propensione a differenziare l’estraneo dalla cerchia di chi si prende cura dei bambini non ha niente a che fare, mi sembra, con il meccanismo della pseudospeciazione: infatti la paura dell’estraneo da parte dei bambini riguar- da soprattutto gli appartenenti allo stesso gruppo ( non credo che i bambini siano portati a contatto di frequente con i “nemici”…). Anche i suoi esempi che riguardano la vita sociale degli scimpanzé mi paiono inaccurati: altro è notare la diffidenza e l’aggressività tra “sani” e “malati”, o episodi di strupro, e sorvolare sulla “divergenza culturale” che porta gli umani non solo a praticare lo stupro di gruppo ( non a caso tipica “arma di guerra” fino alla nostra epoca), ma a uccidere i conspecifici con una impressionante frequenza e niente affatto in situazioni del tutto particolari o per eccezione casuale)
- A. Honneth, Disrespect. The Normative Foundations of Critical Theory,Cambridge U. K. 2007, Polity Press.
- C. G. Jung, Libro Rosso (1913-1951), Bollati Boringhieri, Torino, 2010; E. Neumann, Psicologia del profondo e nuova etica (1949), Moretti & Vitali, Bergamo, 2005. Sul tema del capro espiatorio nei due autori cfr. Il mio C. G. Jung.L’Opera al Rosso, Fel- trinelli, Milano, 2016. Del tutto indipendentemente da questi autori, mai citati nelle sue opere, R. Girard ha dedicato l’intero suo pensiero alla costruzione di una teoria generale del capro espiatorio.
- Su questa dialettica tradizione-innovazione cfr. il mio La carta del senso. Psicologia del profondo e vita filosofica, Raffaello Cortina, Milano, 2012.
- Sul capitalismo globale cfr. il mio L’animale visionario, Il Saggiatore, Milano, 1999.